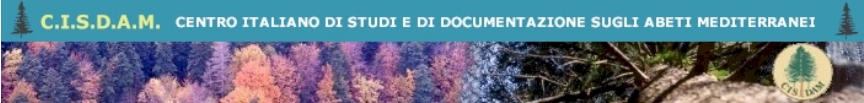
Il Centro italiano di studi e documentazione sugli abeti mediterranei, con sede a Rosello (CH), presso la Riserva Naturale Regionale "Abetina di Rosello", è stato istituito nel 1995 per iniziativa di alcuni naturalisti e ricercatori e conta attualmente oltre 100 soci. Ha per statuto l'obbiettivo di attivare studi e ricerche in vari campi disciplinari, sulle specie del genere Abies, di sollecitare e sostenere tutte le iniziative finalizzate alla tutela e alla conservazione del genere. Più in generale il Centro è impegnato nella promozione della ricerca scientifica nel settore ambientale, paesaggistico, storico, facendo propria, grazie anche alle diversificate competenze degli aderenti, l'esigenza di una lettura interdisciplinare nello studio del territorio. Collabora con diversi Enti quali: l'Università della Tuscia di Viterbo, l'Orto Botanico di Roma, l'associazione Altura, il Paco nazionale d'Abruzzo, il Parco Nazionale della Majella e il WWF Italia. Come attività preparatoria al Progetto Life, Tutela di Habitat con Abete bianco nei SIC nell'Appennino centro-meridionale, è stata prevista un Piano di Azione di conservazione in corso di svolgimento.
Il piano d'azione deve essere considerato come strumento di pianificazione, e alla base deve avere un'adeguata analisi del territorio e una buona conoscenza della realtà nella quale si andrà ad operare. Il carattere di elasticità, non ha permesso un'indicazione temporale degli interventi ben definita, proprio perché il presente documento deve poter essere utilizzato ai diversi livelli di pianificazione esistente e alle diverse condizioni di partenza possibili. Gli obiettivi individuati non devono essere quindi considerati secondo una scala gerarchica rigida o in funzione di priorità già stabilite, ma devono essere interpretati sulla base delle condizioni nelle quali si opera, e realizzati in funzione di queste. L'obiettivo finale da raggiungere non è infatti la massima diffusione dell'abete bianco, ma la ricostituzione della foresta mista appenninica - nel passato caratteristica delle nostre montagne e nella quale l'abete può sviluppare le proprie potenzialità - e la gestione sostenibile della stessa. Attualmente l'abete sull'Appennino è localizzato in nuclei isolati, che testimoniano una presenza passata più diffusa. Le prove di questo ritiro risultano da analisi polliniche, da molteplici documenti d'archivio e da numerosi toponimi.
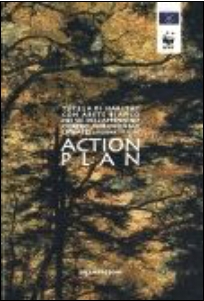
Per questo motivo, particolare rilevanza assume l'analisi dei fattori che hanno giocato un ruolo determinante nel processo di regressione. L'attuale diffusione è fondamentalmente la conseguenza di due fenomeni che, in diversa misura e con differenti modalità, hanno portato ad una netta contrazione della superficie occupata da questa specie. Il fattore climatico è alla base delle recessioni iniziate in epoca storica: per i grandi mutamenti climatici dovuti alle glaciazioni, l'Abies alba ha trovato rifugio nelle zone della penisola più favorevoli, specialmente al sud, e in Grecia. A questi cambiamenti si sovrappone, in modo sinergico, l'azione antropica. Nei secoli scorsi, l'uomo ha esercitato forti pressioni sull'abetina, con frequenti ed estesi disboscamenti che hanno ridotto le possibilità competitive delle specie sciafile come l'abete o il tasso, che si avvantaggiano di lunghi periodi di assenza di disturbo antropico o naturale e hanno irrimediabilmente alterato la capacità riproduttiva della specie, fino a portare alla scomparsa di numerosi nuclei di abete. In rare località il fenomeno è stato abbastanza limitato da permettere il mantenimento delle cenosi originarie: ciò si è verificato dove queste erano poste in zone impervie, che limitavano fortemente l'accessibilità e le possibilità di sfruttamento. In altri casi, è stata proprio l'azione dell'uomo che ha mantenuto o ampliato le abetine preesistenti.