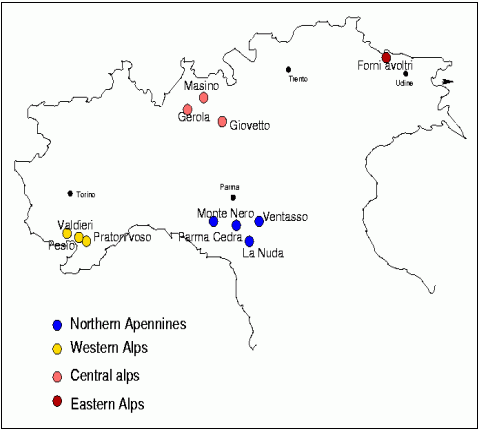
Indagine sui caratteri genetici e di autogenia dei popolamenti di Abies alba nell'appennino emiliano occidentale
Paolo Piovani
Dipartimento di Scienze Ambientali, Universitá di Parma,
Parco Area delle Scienze 11/A 43100, Parma
Nell'ambito del progetto Life-Natura
"Conservazione delle abetaie e delle faggete appenniniche",
che prevedeva interventi per la salvaguardia e l'espansione di 4
popolazioni ritenute autoctone di abete bianco dell'Appennino Emiliano,
é stata svolta un'analisi genetica per verificarne l'origine autoctona.
Queste popolazioni relitte rappresentano ciò che rimane delle
originarie foreste miste di abete bianco e faggio che ricoprivano questa
parte dell'Appennino Settentrionale. 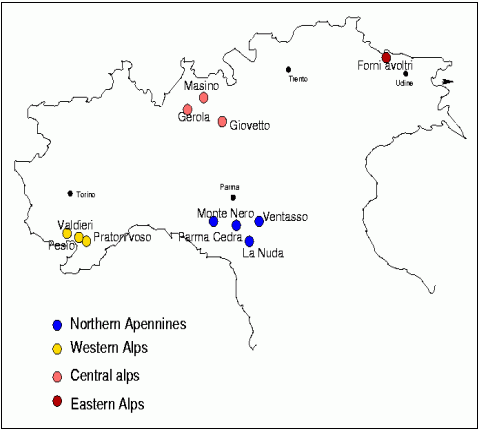
Dopo i pesanti tagli della fine del secolo XIX, la maggior parte delle abieti-faggete sono state sostituite da faggete pure governate a ceduo e le poche aree risparmiate dal taglio, in cui l'abete bianco é sopravvissuto, si trovavano in zone difficilmente accessibili, con elevate pendenze e rocciositá. Inoltre, questi nuclei potevano espandersi con difficoltá a causa della forte competizione del faggio che, soprattutto se governato a ceduo, crea condizioni assai sfavorevoli all'insediamento della rinnovazione dell'abete bianco a causa dell'elevata copertura che non permette alla luce di arrivare a livello del sottobosco. Il progetto Life ha previsto azioni sia in situ, con interventi selvicolturali volti a migliorare le condizioni di vegetazione degli individui giá insediati e a creare una situazione adatta all'insediamento di rinnovazione, sia ex situ con la produzione di piantine da seme proveniente dalle popolazioni salvaguardate successivamente utilizzate per l'allargamento dei nuclei esistenti e per la creazione di nuovi nuclei.L'analisi genetica si é configurata come azione preparatoria, al fine di verificare l'effettiva autoctonia delle popolazioni coinvolte nel progetto. Per questo studio i nuclei emiliani sono state confrontati geneticamente con altri di origine alpina utilizzando marcatori molecolari cloroplastici (Vendramin et al., 1999).
L'analisi é stata effettuata mediante l'utilizzo della tecnica PCR (Polymerase Chain Reaction) che permette di evidenziare differenze tra individui a livello del DNA. É stata successivamente calcolata tra le popolazioni la distanza genetica di Goldstein (Goldstein et al., 1995) ed é stato costruito un albero filogenetico con il metodo Neighbor-Joining (Saitou and Nei, 1987), al fine di valutare le relazioni genetiche esistenti tra esse. I risultati ottenuti hanno evidenziato che i popolamenti emiliani sono affini geneticamente tra loro e si differenziano da quelli alpini piu' lontani. Questo sembra confermare l'origine autoctona di queste popolazioni, soprattutto alla luce della ricolonizzazione postglaciale dell'abete bianco in Italia, che sembra avere riconquistato il suo attuale areale a partire da un rifugio situato in Italia Centrale (Kral, 1979; Huntley and Birks, 1983). Questo fatto quindi giustificherebbe la similaritá genetica riscontrata tra le popolazioni emiliane, confermandone la probabile origine autoctona. Su una delle quattro popolazioni esaminate é stata poi analizzata la variabilitá del controllo stomatico in condizioni di stress idrico, mediante lo studio di tratti legati alla traspirazione in famiglie di half sibs provenienti dal nucleo dell'Alta Val Parma-Cedra, che rappresenta uno dei4 coinvolti nel progetto Life. Questa analisi ha permesso di individuare una variabilitá significativa nella risposta allo stress idrico tra diversi genotipi, confermando la presenza di variabilitá adattativa all'interno della popolazione, che potrebbe permettere di rispondere positivamente a condizioni di diminuita disponibilitá idrica, a causa cambiamenti climatici previsti per le prossime decadi.